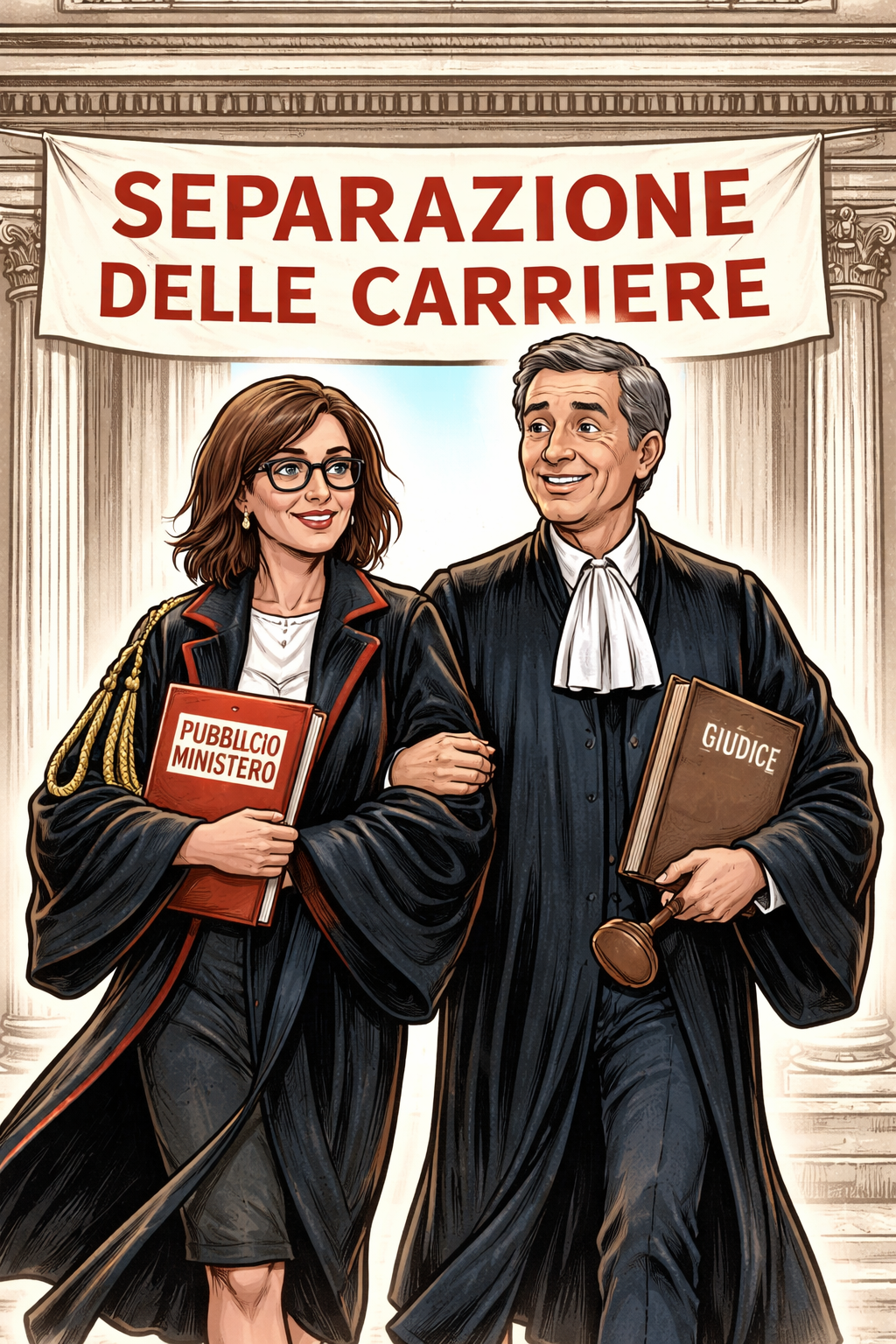Michele Ainis, prendendo spunto dalle la poca affluenza alle amministrative del 12 giugno e del prevedibilissimo flop dei referendum sulla giustizia, ha scritto che perde la democrazia quando diventa una chiesa vuota di fedeli. Calamandrei diceva che non si ha democrazia laddove, pur essendo di diritto tutti i cittadini ugualmente elettori ed eleggibili, di fatto solo alcune categorie di essi dispongono dell’istruzione sufficiente per essere elementi consapevoli ed attivi nella lotta politica. Natalino Irti, giurista, in un suo recente libro (“Viaggio tra gli obbedienti”) ha scritto che a non dubitare sono (solo) le coscienze rese forti dalla fede o disciolte nel tepore dell’opinione comune. Per Dacia Maraini la scuola il più grande investimento di un paese per il futuro (“La scuola ci salverà”). E’noto, aggiungo io, come i paesi dove vi sono alti tassi di corruzione siano quelli in cui non si investe in formazione, educazione, conoscenza e istruzione (cit. Gabrio Forti).
Sulla nostra scuola, invece, regna da sempre il più preoccupante dei silenzi. Sin dal 1958 quando viene approvata la legge istitutiva dell’educazione civica voluta da Aldo Moro, allora ministro della pubblica istruzione. Sono cambiati i nomi. Educazione civica sino al 1985; studi sociali nelle elementari; convivenza civile dal 2008 e Cittadinanza e Costituzione nel 2018. Scambiata come decalogo del buon cittadino il suo destino è quello di essere sempre sacrificata per potere completare i programmi e terminare le interrogazioni. Nel 2019, un attimo prima della pandemia, la legge. n. 92 introduce l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
Restano però incertezze enormi sul futuro della scuola e nessuno si pronuncia. A partire dall’esame di maturità del quale non può non dubitarsi circa il suo senso. Il paese conosce con ampio anticipo chi sarà il conduttore di Sanremo e le sue immancabili compagne di viaggio ma continua a rimanere impossibile per una famiglia sapere se e quale insegnante condurrà la classe del proprio figlio al termine dell’anno scolastico. Si legge che i livelli raggiunti dai nostri ragazzi, una volta diplomati, siano paragonabili agli studenti delle scuole medie. Che a scuola si scrive davvero poco. Che la lezione frontale è ormai antica e superata. Si lamenta una didattica che non vede gli studenti come protagonisti. Non manca il tema degli insegnanti dequalificati professionalmente.
Tutti concentrati sul come insegnare ma poco attenti a cosa insegnare. Ai programmi. Sono questi ultimi al passo con i tempi che cambiano? Il Ministero dell’istruzione si occupa -oltre che della gestione degli insegnanti- della formazione degli studenti? E’ azzardato chiedere che il legislatore torni, anche per il tema scuola, a essere un legislatore coraggioso? La richiamata legge sulla educazione civica non mi pare sia proprio un esempio di coraggio.
La più parte dei giovani è pericolosamente indifferente alla vita pubblica, ignorando quali siano e cosa rappresentino le istituzioni. La più part di loro non è in grado di decodificare quanto avviene fuori dalle finestre alle quali si affacciano. Forse non sono stati forniti loro gli strumenti per farlo.
Se tutte queste considerazioni sono anche solo parzialmente attendibili, la legge n.92/2019 rappresenta una sfida. Affida infatti -forse con eccessiva retorica - proprio alla educazione civica il compito di “contribuire a formare cittadini responsabili e attivi, promuovendone la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Obiettivo ritenuto raggiungibile sviluppando nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea (così recita la legge).
Credo si imponga un restyling dei mezzi di trasmissione delle materie. Anche di quelle giuridiche il cui insegnamento è sempre stato un’ eccezione. Conoscere come si approva una legge non è affatto superfluo. Avere consapevolezza che una legge è il risultato di una mediazione è un punto di partenza importante perché solo così si potrà rivalutare e capire l’importanza di un eventuale referendum, al netto delle indecenze della politica e dei quesiti (volutamente o colposamente) incomprensibili. Non è scontato sapere come nasce e finisce una crisi di governo, dando invece per scontato che si abbia almeno una qualche consapevolezza di quale sia la funzione del potere esecutivo. Non è una perdita di tempo sapere cosa sia un contratto, solo considerando che ogni giorno ne concludiamo di diversi (di contratti). E’ assai utile avere quale rudimentale nozione in tema di riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro. Il covid lo ha dimostrato. E’ grave ignorare l’ambiente e il territorio; non sapersi orientarsi nella normativa civilistica e fiscale quando già a 16 anni un ragazzo/a inizia a districarsi tra incarichi, contratti di lavoro, retribuzioni. I diritti e i doveri che leggiamo nella Costituzione devono assumere concretezza. Tangibilità.
Una legge -quella dedicata alla educazione civica -che mai la definisce ma ne chiarisce quale tratto peculiare la trasversalità. Espressione che ha alimentato discussioni, incertezze, interpretazioni. Le più diverse. Una che trovo corretta è quella peer cui i temi della educazione civica sono già implicitamente espressi nelle discipline curriculari. Ciascun docente dovrà necessariamente fare volgere la propria offerta disciplinare verso pratiche esperienziali. Su tanto credo si giochi il senso della nuova legge n. 92. Ciascun insegnante dovrà praticare la propria esperenzialità tenendo come riferimento la Costituzione, scoprendo tra i suoi articoli quelle trame che potranno costituire un ponte con i contenuti di ogni singola materia di insegnamento.
La trasversalità può essere realizzata anche con diverse gradazioni e strategie, qualora -per qualsiasi motivazione- non sia percorribile la strada di una radicale interdisciplinarietà. Nulla vieta che all’interno del consiglio di classe si possano individuare dei temi o argomenti affini solo ad alcune o a tutte le discipline per ricondurle intorno alle tre macro-aree facendo emergere i nuclei tematici disciplinari volta a volta più adeguati e funzionali alla costruzione del curricolo. La flessibilità sembra rappresentare l’approccio più realistico e promettente all’impostazione del nuovo insegnamento, ed anche il più coerente con il suo carattere sperimentale.
Collegio docenti e consigli di classe non possono che essere contitolari dell’insegnamento della nuova educazione civica. Una responsabilità collegiale che permane anche se fra i docenti vengono individuati dei coordinatori che hanno il compito di gestire lo svolgimento delle attività e di formulare una proposta di valutazione, acquisite le necessarie informazioni da parte dei colleghi del consiglio di classe. Credo di potere interpretare in senso conforme allo spirito della legge che l’insegnante di materie giuridiche, quando previsto, non è affatto titolare di una esclusiva all’insegnamento dell’educazione civica che, occorre ricordar, non è una variante o estensione di diritto ed economia. Se non si coglie questo aspetto la legge è destinata a fallire.
Purtroppo l’insegnamento dell’educazione civica prevede una valutazione specifica. Una scelta che evidentemente il legislatore ha compiuto per sottolineare l’importanza di questo insegnamento. A mio modo di vedere assolutamente incoerente con la ratio della legge. Agli occhi degli studenti sarà percepita come altra materia. Il legislatore non ha avuto il coraggio di prescindere dal voto, unico motore della scuola anche se nelle linee guida viene sottolineato che la valutazione degli apprendimenti dell’educazione civica non deve, né può, intraprendere la via della classica verifica-misurazione disciplinare, in quanto essa deve riguardare il conseguimento delle competenze e non l’acquisizione (fine a sé stessa) dei contenuti. Parole sempre altisonanti. Forse sarebbe stato più semplice eliminare il voto. In ogni caso la valutazione è proposta dal docente coordinatore, sentiti gli altri docenti; quindi il voto sarà la risultanza del parere espresso a un docente coordinatore da tutti i docenti coinvolti. Nella scuola primaria, essa avrà la forma di un giudizio descrittivo; nella secondaria di primo e di secondo grado verrà espressa con un voto in decimi. Il voto concorre all’ammissione alle classi successive e/o all’esame di stato, e nella secondaria superiore alla formazione del credito scolastico.Le competenze conseguite in educazione civica influiranno inoltre sulla valutazione del comportamento dell’alunno.
Per il primo triennio (anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23) non sono volutamente indicati obiettivi e traguardi specifici di sviluppo delle competenze per questo insegnamento. Ogni istituto provvede autonomamente avendo come punto di riferimento le linee guida. Successivamente il Ministero, raccolte le informazioni sul campo, diramerà le proprie direttive. Sono però state individuate tre macro aree. Costituzione, educazione ambientale, cittadinanza digitale. Tante le micro-aree: il rispetto per gli animali, l’attenzione per la raccolta differenziata o la lettura dei complessi problemi energetici e climatici del pianeta, la sostenibilità delle città o delle società, la capacità di includere le minoranze e le differenze, il rispetto per i diritti di ciascuno; l’alfabetizzazione consapevole all’uso di strumenti che ormai ragazzi frequentano dalla nascita; i rischi della rete; dalle fake news; le svariate forme di bullismo elettronico. Una legge che avendo optato per la trasversalità dell’insegnamento rischia di rivelarsi evanescente proprio per l’enorme quantità di contenuti e obiettivi.. Di qui forse , come vedremo, il tentativo di ancorare l’EC a una tematica interdisciplinare/trasversale forte. Le sfide più importanti per i docenti saranno la programmazione (principio della trasversalità), la gestione collegiale attraverso i coordinatori (principio della contitolarità), i criteri e le modalità di valutazione.
Rimane un ulteriore limite ed è quello di “metterci le ore”. L’insegnamento, obbligatorio in tutte le scuole di ogni ordine e grado, avrà un orario annuale non inferiore a 33 ore. Certo, potrebbe essere di più di 33, ma l’importante è che non siano meno. Si tratta di un monte ore da individuarsi all’interno del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. Tradotto, ciascuna materia lascia qualcosa alla nuova arrivata educazione civica. Scelta discutibile, che denota sempre sul poco coraggio del legislatore gettando più che una insinuazione sulla creduta importanza di questa educazione civica. Una preoccupazione da molti condivisa per cui il timore è che questa nuova e trasversale educazione civica venga vissuta come ulteriore più come appesantimento burocratico che come una buona occasione per cambiare il corso non della storia ma della scuola. Lamentarsi dopo, serve a poco.