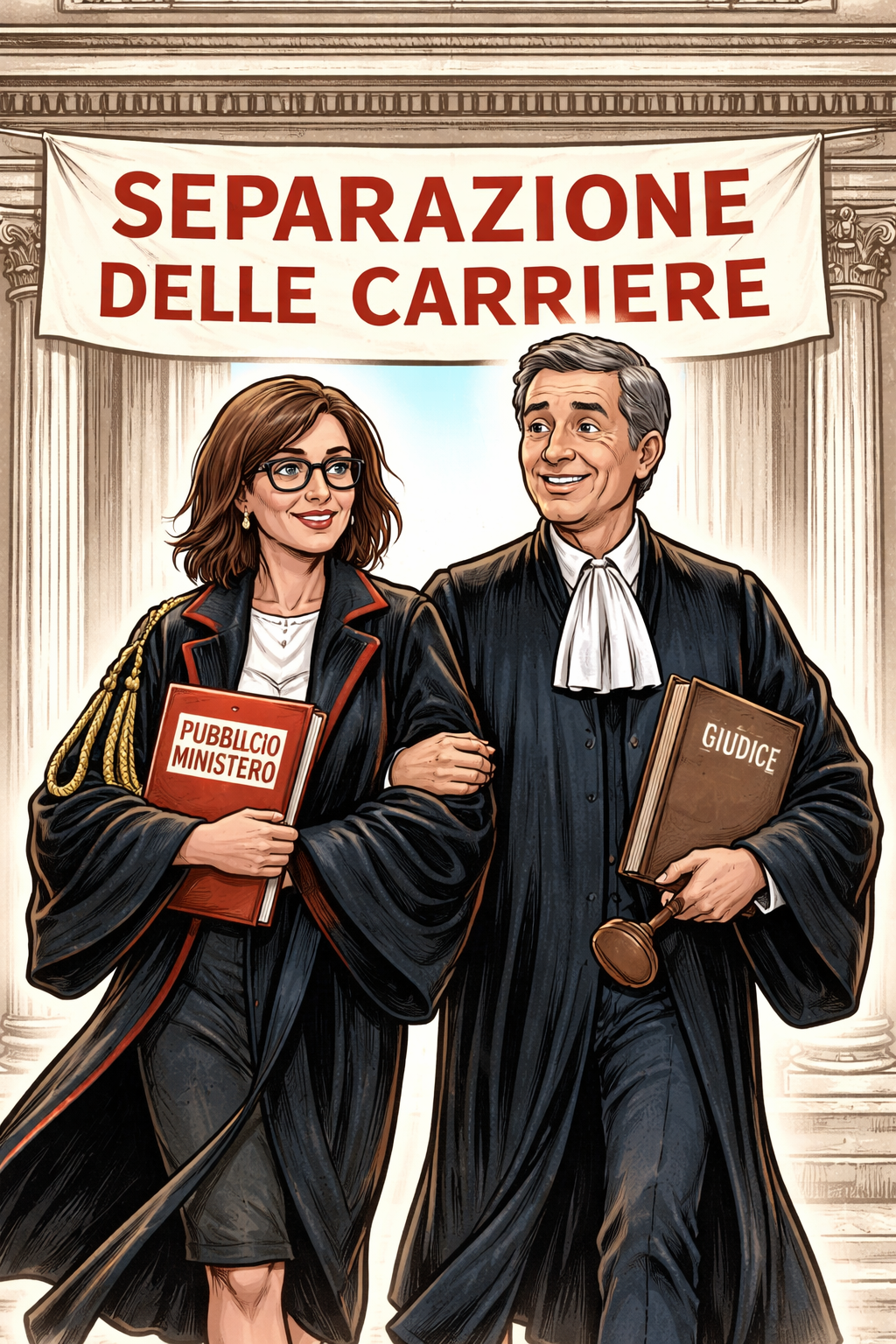Con la Legge 20 agosto 2019, n. 92 il Parlamento italiano quasi all’unanimità, particolare che non è affatto irrilevante, ha introdotto l’obbligo dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado (scuola primaria e secondaria). Una maggioranza di 193 voti favorevoli e 38 astenuti nello stesso testo già approvato dalla Camera tre mesi prima con nessun voto contrario e soli 3 astenuti. Un consenso pressoché unanime. Una legge. la cui applicazione viene posticipata all’anno scolastico 2020-2021, quello della pandemia.
La prima domanda che dobbiamo porci è il perché di questa legge.
Una legge sdoganata come necessaria, non oltremodo differibile per lenire la preoccupazione verso un universo giovanile e adolescenziale creduto ormai allo sbando. Genitori additati come incapaci di sapere educare, istruire, fare crescere con assennatezza i propri figli. Una certa giurisprudenza, quella più più severa, segnala un pericoloso e maligno concorso di una scuola non sempre all’altezza della propria funzione. Una scuola che inevitabilmente accusa l’inidoneità di una politica sempre in ritardo e con il fiato corto. Leggendo i lavori parlamentari ricorderemo come fosse palpabile la preoccupazione per l’universo scolastico e giovanile in genere: reiterai episodi di razzismo, rifiuto degli immigrati, violenza sulle donne, bullismo, emergenza ambientale. Disagio giovanile in aumento, aggravato oggi dalla situazione di pandemia. Livello di scolarizzazione non eccelso.
Siamo davanti al solito gioco di specchi attraverso cui una società cerca di mostrarsi migliore di quanto effettivamente non sia? Viene approvata questa legge sol perchè la collettività ne è in attesa e così può creder che sia stata fatta una legge importante su un tema non oltremodo differibile?Non è una domanda impertinente o maliziosa o finanche inconferente. E’ La domanda che occorre sempre porsi davanti ad una nuova fonte del diritto anche se la risposta fisiologicamente tarderà a giungere.
Dal 1958 – anno di approvazione della legge istitutiva dell’educazione civica voluta da Aldo Moro, allora ministro della pubblica istruzione – l’insegnamento della educazione civica non è mai decollato tanto che 61 anni dopo il Legislatore ha sentito il bisogno di approvare una legge ad hoc. Una educazione civica che negli anni ha perso completamente l’innegabile valore sino a divenire, nell’immaginario collettivo, una sorta di galateo delle buone maniere. Ha cambiato più volte il nome questo insegnamento, sempre posticipato al dovere incombente sui docenti di completare i programmi e terminare le interrogazioni. Di assolvere alle questioni amministrative-burocratiche che dettano i tempi dell’iter e dei programmi scolastici. Solo il tempo potrà confermare o smentire le aspettative riposte in questa legge e allontanare il sospetto che si tratti solo di una opportuna operazione di facciata.
Non vi è chi non veda il tema dell’istruzione come prioritario. Piero Calamandrei ricordava come non si ha democrazia laddove, pur essendo di diritto tutti i cittadini ugualmente elettori ed eleggibili, di fatto solo alcune categorie di essi dispongono dell’istruzione sufficiente per essere elementi consapevoli ed attivi nella lotta politica. Questa nuova legge, almeno nelle aspettative, sembra figlia di quelle parole. Soprattutto oggi dove è posta sotto accusa la tradizionale lezione frontale, ritenuta ormai antica e superata. Dove viene denunciata da più parti una pericolosa latitanza di stimolazione, motivazione, fascinazione della scuola. Una mediocrità e finanche anacronistica sopravvivenza di programmi scolastici ritenuti ormai inadeguati e non al passo con i tempi. Uno scollamento tra ciò che si impara a scuola e quello che serve dopo la scuola. Per alcuni non oltremodo accettabile mentre per altri il vero vulnus.
-Lo studio della Costituzione italiana-
Riuscirà questa legge a rendere i nostri studenti meno indifferenti alla vita pubblica? A spingerli a guardare fuori dalle finestre delle loro classi e tentare di decifrare i grandi temi della nostra epoca? Delle loro vite, quelle che proseguiranno (per alcuni inizieranno) solo dopo avere conseguito quell’ oscuro e discusso oggetto del desiderio che è la “maturità”. Quella scolastica, che è ancora alla disperata ricerca di un suo proprio senso. Questa, credo di avere capito, è la sfida che ci pone questa nuova legge al netto della insopportabile retorica e demagogia che riempie il testo normativo che affida alla educazione civica compiti irraggiungibili perchè evanescenti (è sufficiente leggere la legge e le successive linee guida). Si legge “di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi, promuovendone la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri» (art. 1). Compito realizzabile sviluppando nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea. Quella Costituzione la cui conoscenza è posta a fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica (art. 4).
Da ormai tanti anni svolgo la professione di avvocato e di insegnante di diritto alle superiori. Una intersecazione felice tra queste due attività che rendono più affascinante la seconda delle due, che quotidianamente e forse, senza saperlo, in questi lunghi anni è stata una sorta di inconsapevole anticipazione di quello che oggi vuole essere il nuovo senso dell’educazione civica rivitalizzata da una legge, quella approvata nell’agosto delle 2019, che temo rimanga scritta nel testo. Quando un insegnante racconta la Costituzione ai suoi studenti cosa legge nei loro occhi? Prima stupore e poi incomprensione, quindi fastidio. Stupore perché libertà e eguaglianza appaiono diritti scontati. Incomprensione perchè quello studente si rende immediatamente conto che poco di quanto c’è scritto nella carta costituzionale corrisponde a ciò che sperimenta nella sua pur giovane vita reale. Fastidio per il fatto che ci si ostini a spiegargli “regole” che nessuno rispetta e che vedono violate tutti i giorni, da chiunque. Magari, anche vicino a quello stesso adolescente. Qui diventa essenziale il ruolo di colui che “racconta” la costituzione, che deve spiegare quella che è la sottile differenza tra una costituzione non (ancora) attuata e inattuale.
-Trasversalità dell’insegnamento di educazione civica-
E’ forse maturo il tempo per un vero e proprio restyling dei mezzi di trasmissione del sapere e delle conoscenze, qualunque sia la materia e tra queste soprattutto quelle giuridiche il cui insegnamento è, purtroppo, sempre stato una eccezione. Evidente aporia dal momento che il diritto, le regole, sono ovunque, soprattutto nella scuola dove i ragazzi passano una parte non indifferente della loro vita. E, per le scuole primarie e secondarie, si tratta di un periodo particolarmente delicato di essa.
Tratto peculiare legge n. 92 del 2019 è la trasversalità nel senso che è pensata in una prospettiva di attraversamento e integrazione delle diverse discipline. Con riferimento a queste educazione civica non è una variante o estensione di diritto ed economia. Aspetto questo che se non viene colto temo segnerà il fallimento della legge. Se prevista nell’organico di una certa scuola, la figura dell’insegnante di materie giuridiche potrà essere fisiologicamente ritenuto coordinatore senza che in tanto si possa individuare una sorta di privilegio acquisito o diritto quesito. Corollario della trasversalità è la collegialità. Collegio docenti e consigli di classe sono contitolari di tale insegnamento. Una contitolarità che si trasforma in responsabilità collegiale che permane anche se fra i docenti vengono individuati dei coordinatori che hanno il compito di gestire lo svolgimento delle attività e di formulare una proposta di valutazione, acquisite le necessarie informazioni da parte dei colleghi del consiglio di classe. Tutti i docenti sono chiamati a condividere gli obiettivi, gli strumenti e da ultimo la valutazione di questo insegnamento.
Il termine trasversalità è forse nuovo ma il suo significato accompagna da sempre l’educazione civica. La Costituzione italiana, ma lo stesso dicasi per ogni carta fondamentale, riflette il modo di essere di un determinato popolo. E’ evidente che per comprenderne i suoi principi e le sue regole non si può non conoscere la storia di quel popolo e di quella nazione; il pensiero filosofico che ha ispirato i suoi padri costituenti, la geografia, i confini, il territorio, la sua religione, la sua economia. E mi chiedo cosa sia tutto questo se non trasversalità.
-Il monte ore: una prima non sottovalutatile criticità
All’insegnamento dell’educazione civica come qui declinata è stato riservato un orario annuale non inferiore a 33 ore da individuarsi all’interno del monte ore complessivo previsto dagli ordinamenti. Tradotto, significa che ciascuna materia lascia qualcosa alla nuova arrivata, educazione civica. Scelta più che discutibile, che denota e riflette poco coraggio del legislatore gettando un pericoloso discredito circa la creduta e sbandierata importanza di questa novità. Un retaggio del passato che, di fatto, ha determinato una vera e propria evaporazione dell’educazione civica.
- La valutazione : una seconda non sottovalutatile criticità -
Ancora più discutibile la prevista valutazione specifica, non incorporata cioè all’interno di quella di altre discipline. Una scelta che, evidentemente, il legislatore ha compiuto per sottolineare l’importanza di questo insegnamento ma, temo, assolutamente incoerente con la ratio della legge. Agli occhi degli studenti sarà percepita come “altra materia”. Si è forse temuto che altrimenti gli studenti non avrebbero trovato motivo per frequentare le ore di educazione civica? Verosimilmente si, questo è stato il timore. Un depotenziamento inaccettabile del senso di questa annunciata riforma.
Peraltro la valutazione come concepita ex lege collide con la trasversalità, tratto peculiare di questa proposta educativa. Come anticipato trasversalità significa che i temi di questa nuova disciplina sono già implicitamente espressi in tutte le discipline curriculari. E la trasversalità deve essere praticata nella e attraverso l'esperenzialità, nel fare esercizio di quei principi costituzionali che, ovviamente, prima di essere riconosciuti dovranno essere conosciuti. Ma se questo è il dna della legge n. 92 del 2019 che senso ha una valutazione che altro non può essere che atto immediato, temporalmente successivo alla prima fase, quella appunto della conoscenza che solo poi, in momenti successivi e gradualmente (appunto esperenziale) diventa attività di riconoscimento di una esperienza? Gli obiettivi di questa nuova proposta scolastica non possono che essere a lungo, lunghissimo termine, non riconducibili, incasellati e certificati da burocratiche quantificazioni. Opportuni, in questa ottica, i contatti tra scuola e realtà esterna nelle sue diverse forme e organizzazioni.
Da sempre si critica ferocemente la scuola italiana ritenendola nozionistica, legata al passato e disinteressata al futuro, scollata dal mondo reale. A colpi di riforme si è cercato, dapprima negli indirizzi professionali e poi finanche nei licei, di eliminare questo “gap” (penso all’’alternanza scuola lavoro). L’incertezza è proprio l’approccio che la scuola, gli alunni, le famiglie, la società avrà con questa “nuova” filosofia di cui la legge n.92 si fa portatrice. Se ciascun attore ne saprà cogliere le reali potenzialità è legittima una previsione benigna. Altrimenti sarà l’ennesimo fallimento del sistema scolastico.
- I contenuti della nuova educazione civica -
E’ stato previsto un voto ma non sono stati previsti i contenuti. Almeno per il primo triennio (anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23) dove viene lasciata piena autonomia e fantasia alle scuole, agli insegnanti, ai collegi docenti e ai consigli di classe che dovranno basarsi sui Piani dell’offerta formativa nonché richiamandosi alle linee guida. Successivamente il Ministero, raccolte le informazioni sul campo e quindi esaurito il triennio “sperimentale” diramerà (forse) le proprie direttive. Ancora poco chiare le idee. Sono state individuate tre macroaree: costituzione, educazione ambientale, cittadinanza digitale. Ciascuna di queste infarcita di tanti, troppi, temi. La legge come detto ha optato per la trasversalità dell’insegnamento, ma l’enorme quantità di contenuti e obiettivi potrebbe renderla di nuovo evanescente. Le sfide più importanti per i docenti saranno la programmazione (principio della trasversalità), la gestione collegiale attraverso i coordinatori (principio della contitolarità), i criteri e le modalità di valutazione. Tre tematiche strettamente connesse. Non sarà possibile alcuna reale contitolarità se non sulla base di una programmazione condivisa (a cominciare dal banale ma per nulla irrilevante problema del “chi ci mette le ore”, dato che l’orario non si può aumentare). La trasversalità potrà essere realizzata anche con diverse gradazioni e strategie, qualora -per qualsiasi motivazione- non sia percorribile la strada di una radicale interdisciplinarietà. Nulla vieta che all’interno del consiglio di classe si possano individuare dei temi o argomenti affini solo ad alcune o a tutte le discipline per ricondurle intorno alle tre macro-aree facendo emergere i nuclei tematici disciplinari volta a volta più adeguati e funzionali alla costruzione del curricolo. La flessibilità sembra rappresentare l’approccio più realistico e promettente all’impostazione del nuovo insegnamento, ed anche il più coerente con il suo carattere sperimentale.
Diversamente affiora inevitabile una preoccupazione: siamo sicuri che questa novità non venga vissuta come ulteriore appesantimento burocratico non cogliendone invece la sua potenzialità che pure c’è?