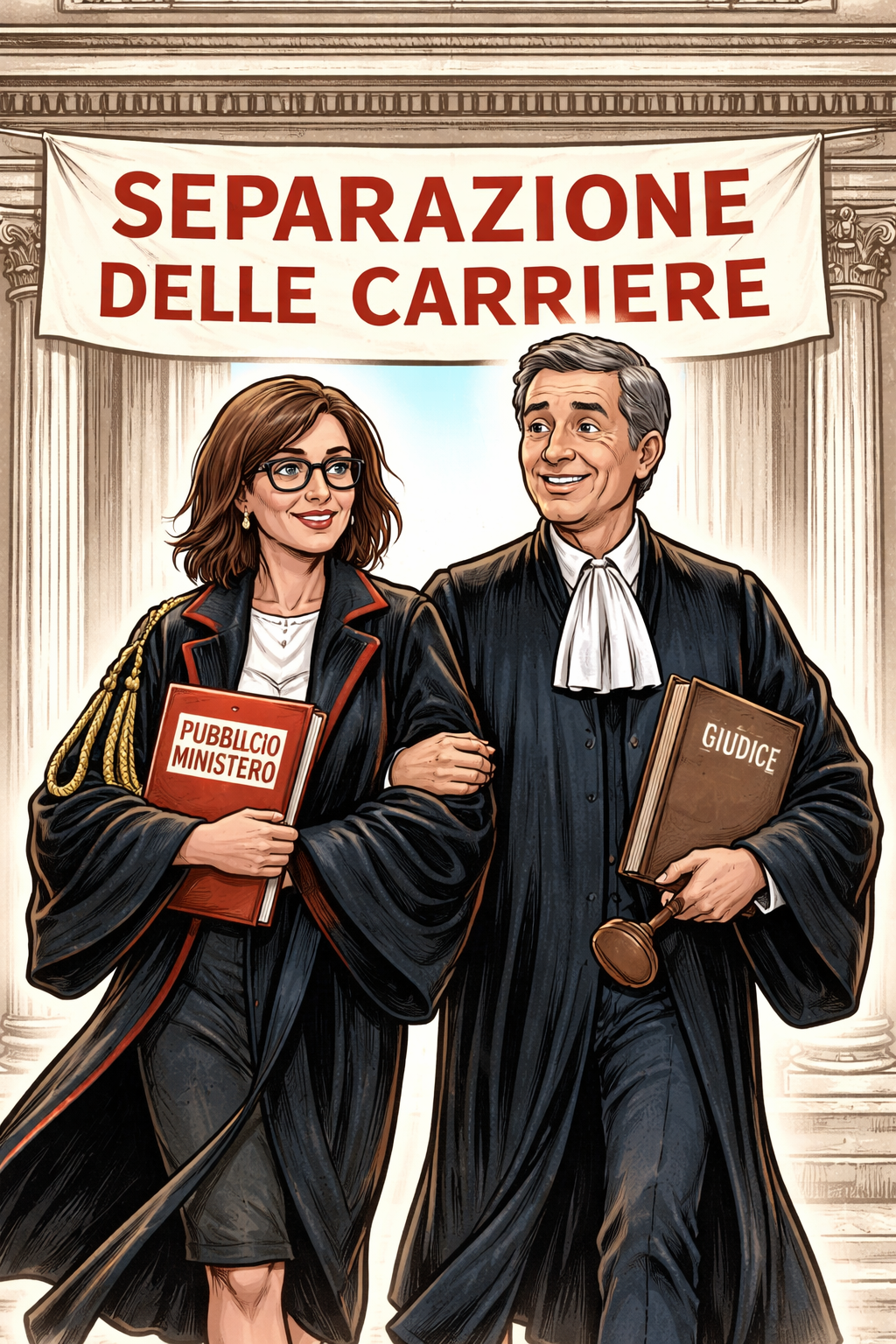Il fatto è il seguente. Un cane tenuto al guinzaglio morde il polpaccio di un ragazzino che inavvertitamente gli era passato sulla coda con le ruote. Fatto che, sia pure con varianti, non è infrequente (si pensi a chi inavvertitamente pesti la coda di un cane). Nel caso specifico il Giudice di Pace ha ritenuto integrato il reato di lesioni colpose in danno delle ragazzino.
La Cassazione (Cass. pen. n. 50562/2019) non è stata dello stesso avviso censurando la non chiarezza della dinamica del fatto come emersa avanti al giudice di pace e, in particolare, il fatto che non sia stato chiarito se il cane fosse o meno al guinzaglio al momento del morso e, soprattutto, se avesse subito o meno il passaggio della bici sulla coda, circostanza peraltro ritenuta dal giudice a quo fatto irrilevante.
La Cassazione pur ribadendo che la posizione di garanzia incombe come un macigno su chi detiene un cane, chiarisce che essa non può non tenere conto di fatti specifici idonei a ridurla, inficiarla, ragionando diversamente in termini sol civilistici di probabilità ex art. 2052 cc e non di certezza, come invece si conviene nell’accertamento di una responsabilità penale.
Inevitabile l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame della vicenda.
Ciò premesso, occorre subito avvertire il gentile lettore che così come “una rondine non fa primavera”, una pronuncia come quella in commento non equivale certo ad un orientamento della giurisprudenza. Perché nella vicenda evidenziata veniva contestato un reato, quello di lesioni mentre sarebbe interessante interrogarsi su quale potesse essere l’epilogo in sede civile (dove viene domandato non l’accertamento di un reato quanto il diritto ad un risarcimento di un danno). E perché nel caso riportato la Cassazione si è limitata a censurare la non chiarezza della dinamica del fatto come emersa avanti il giudice di prime cure (se il cane fosse o meno al guinzaglio e se avesse subito o meno il passaggio della bici sulla coda) e per tale motivo ha rinviato al giudice per un nuovo esame della vicenda.
Vicenda che, come anticipato e prescindendo per un attimo dalla sua riconducibilità al codice penale o civile, rappresenta una ipotesi che nella realtà può verificarsi con una certa frequenza. La “legittima difesa” riconosciuta al cane è certo un principio che in un ordinamento come il nostro, di chiara matrice antropocentrica, forse induce ad un amaro sorriso. A tale proposito mi piace richiamare una interessantissima lettura provocatoria dell’art. 2052 c.c ( da “Cultura giuridica e diritto vivente,Vol.6 2019, Riccardo Bianchini, Diritto umano e diritto animale: una lettura provocatoria dell’art. 2052 c.c”).
La vicenda presa a pretesto per questa provocazione riguarda un cane che beve da una ciotola d’acqua quando un altro cane si avvicina alla medesima ciotola cercando anche lui di bere. Nasce una una colluttazione fra i due cani e quello arrivato dopo avrà la peggio. Scrive Bianchini che nessuno può pretendere da un animale non umano che esso abbandoni lo schema comportamentale che, in termini umani, potremmo chiamare del “farsi giustizia da sé”, ossia del ricorrere allo scontro fisico più o meno violento per stabilire le gerarchie del gruppo. Seguendo questo ragionamento“né il primo cane sfidando il secondo si è posto in termini -per così dire, se esistesse un diritto animale –antigiuridici, né si è posto in tali termini l'altro che ha reagito: e tantomeno lo ha fatto quello dei due che ha inferto un danno all’altro”.
Il diritto umano invece una soluzione deve trovarla. La “colpa”, presupposto del reato di lesioni oppure di una responsabilità oggettiva del proprietario del cane che ha reagito. Una responsabilità che ha come presupposto l’idea che il proprietario del cane che ha sfidato l'altro non è meno responsabile del proprietario del cane sfidato posto che entrambi i proprietari avrebbero dovuto evitare la possibilità dello scontro (è il problema delle c.d zuffe tra cani).
Siamo sinceri. La responsabilità dovrebbe ricadere sul proprietario dell'animale che non ha evitato lo scontro ma - scrive sempre Bianchini in questa sua deliziosa lettura provocatoria- nel mondo animale è impensabile eliminare lo scontro fisico tra i singoli membri del gruppo per stabilire le gerarchie sociali. E dunque solo una lettura più “spinta” della nozione di caso fortuito potrebbe condurre ad un mutamento di pensiero, una lettura tale da farvi rientrare anche i comportamenti degli altri animali. Diversamente, come accade, chiunque sia il danneggiato, a prescindere dalle cause che hanno portato allo scontro fra animali, ha diritto ad essere risarcito.
Un cenno al profilo penalistico. E’ principio ormai consolidato quello per cui grava sul proprietario-detentore dell’animale una posizione di garanzia che impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi laddove la pericolosità non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.
Quanto al profilo civilistico solo il caso fortuito salva il proprietario dell’animale laddove per caso fortuito si intende un un fattore esterno alla causazione del danno che presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e eccezionalità, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo. Rientra in tale ambito il fatto del terzo e il fatto colposo del danneggiato che abbiano avuto comunque efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Sia comunque chiaro che il danneggiato deve comunque dimostrare il nesso eziologico tra il fatto dell’animale e il danno subito, con l’effetto, tuttavia, che, in difetto di tale prova, la sua domanda viene rigettata a prescindere dall’accertamento del fortuito. Una volta assolto dal danneggiato il suo onere probatorio, incombe al danneggiante non già la prova negativa della propria assenza di colpa, ma quella positiva della ricorrenza del fortuito.
Un’ultima “moralistica”riflessione. Al netto di ogni considerazione è sempre opportuno non lasciare il proprio animale libero di correre nei parchetti pubblici, privo di guinzaglio ed eventualmente di museruola se avesse consapevolezza di condurre un cane problematico. Ci sono le aree dedicate e, all’interno di queste, i cani possono fare quello che vogliono. All’esterno no. Lo dicono le ordinanze e i regolamenti comunali. Ma noi continuiamo a fregarcene, appellandoci alle giustificazioni più diverse, alcune anche fondate (il problema della manutenzione di queste aree dedicate è noto) altre un po' meno. Poca importa. Esistono delle regole. Rispettiamole. La conflittualità condominiale originata da situazione legate alla detenzione di animali domestici è alta. Non alimentiamola con il nostro comportamento irrispettoso. A volte le brutte storie sono originate da fatalità, altre volte da colpevole sopravvalutazione. Quasi sempre evitabili con una preziosa prevenzione, che prescinde -ma non può ignorare- il discorso riferibile a quelli che vengono definiti cani impegnativi dove, volendo sintetizzare al massimo, una diversa ampiezza della mandibola o mascella del cane fa la differenza.